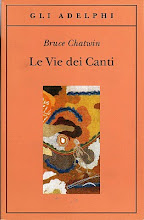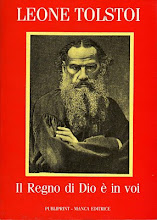Scrittore viaggiatore. Come sempre inserire un autore in un genere letterario è riduttivo. O allora bisogna considerate scrittore viaggiatore anche Proust nella sua stanza tappezzata di sughero. Perché Nicolas Bouvier nei suoi libri parla soprattutto dell'Uomo, delle sue debolezze e delle sue grandezze, dell'incoerenza e della generosità delle sue azioni. Dunque semplicemente scrittore, un bravo scrittore, di quelli che vi aiutano a pensare, capace, grazie alla sua sensibilità, di trasmettere impressioni ed emozioni perspicaci e penetranti.
Nel 1953, quando con il suo amico pittore Thierry Vernet parte verso l'oriente, la guerra è ancora un avvenimento recente. L'Europa, (il mondo), ha appena cominciato la sua ricostruzione e il turismo di massa non è ancora stato inventato. Il loro viaggio, a bordo di una topolino che in salita bisogna spingere, su strade difficili e sconosciute, ha ancora il sapore di esplorazione e di scoperta. Con pochi soldi in tasca, i due cercano di racimolare il necessario vendendo, difficilmente, disegni e articoli per i giornali. Attraversano la Yugoslavia, la Grecia, la Turchia, l'Iran, il Pakistan, prima di separarsi, dopo un anno e mezzo, a Kabul.
Quali sono le ragioni che li spingono a partire? La voglia di conoscere nuovi posti e persone differenti, il desiderio di rinunciare alla monotonia e alla ripetitività del quotidiano ma, in definitiva, semplicemente l'opportunità che si presenta e che permette di concretizzare una fantasticheria: in questo caso del tempo a disposizione e Thierry, in Yugoslavia per un'esposizione e che invita l'amico a raggiungerlo. Così, racconta Bouvier, il fascino che l'adolescente aveva per le carte geografiche, se poi persiste, all'occasione, senza una ragione precisa né un obiettivo ben chiaro, ci mette in viaggio.
Un viaggio non ha bisogno di motivi. Non ci mette molto a dimostrarvi che trova in se stesso la propria giustificazione.
Nel libro La polvere del mondo Nicolas Bouvier ritraccia il percorso in un racconto ricco di spunti e di riflessioni sul mondo che lo circonda ma anche su se stesso. Il titolo originale L'usage du monde L'uso del mondo sottolinea anche le nozioni di conoscenza, apprendimento e approfondimento, di trasformazione nel rapporto verso l'esterno ma anche interiore: Crediamo di fare un viaggio, ma ben presto è il viaggio che ci fa, o ci disfa.
L'idea di partenza corrisponde prima di tutto alla volontà di cominciare una nuova fase nella propria esistenza. « Come la seconda vita di un gatto che ne ha sette » dice l'autore nella premessa. Disponibile a lasciarsi alla spalle non solo i legami materiali ma anche le proprie certezze, il viaggiatore parte con lo spirito di chi non pensa al ritorno: il viaggio non è un periplo. Nicolas Bouvier et Thierry Vernet hanno approssimativamente programmato un itinerario,- verso l'India e forse più in là,- ma il percorso e la durata sono lasciati al caso. Ed è così che dopo essere andati alla ricerca di villaggi zingari in Serbia, dopo essersi fermati in Macedonia, attraversano in modo relativamente rapido la Grecia e l'Anatolia per poi restare un inverno intero, bloccati dalla neve, a Tabriz in Iran.
Riuscendo a raggranellare di che vivere, anche se spesso in modo molto parsimonioso, i viaggiatori rinunciano ad agni lusso ma non al più prezioso: la lentezza.
E il desiderio di lentezza, arriva fino al rimpianto e all'aspirazione per un luogo in cui fermarsi, un covo da riempire con la scrittura e le letture. Forse per questo la scrittura di Nicolas Bouvier sembra oscillare tra il desiderio del viaggio e la nostalgia del rifugio.
Il viaggio dà occasioni per scuotersi ma non -come si potrebbe credere- la libertà. Ci fa piuttosto provare una specie di riduzione: privato della sua cornice abituale, spogliato delle sue abitudini come di un imballaggio voluminoso il viaggiatore si trova ridotto a più umili proporzioni. Ma anche più aperto alla curiosità, all'intuizione, al colpo di fulmine.
I panorami, i paesi, le città sono l'intelaiatura del racconto; descritti in dettagli più che in affreschi ma che, proprio per questo, sono più efficaci e parlanti. E i paesaggi non sono mai per Bouvier cartoline illustrate. A volte suscitano in lui sensazioni di avversione e di ostilità: paesaggi che ci aggrediscono e che bisogna abbandonare immediatamente per evitare conseguenze incalcolabili.
Ma altrove generano momenti di grazia, sufficienti a giustificare ore di fatica e di sconforto:
Per un motivo o per l'altro, può succedere di fermare l'auto e di passare la notte all'aperto. Al caldo in una grossa giacca di feltro, un berretto di pelliccia calato sulle orecchie, si ascolta l'acqua bollire sul fornello, al riparo di una ruota. Accostati ad una collina, guardiamo le stelle, i movimenti lenti della terra che se ne va verso il Caucaso, gli occhi fosforescenti di una volpe. Il tempo passa in té scottante, in rare parole, in sigarette, poi l'alba si leva, si distende, le quaglie e le pernici si fanno sentire... e ci si affretta a colare questo sovrano istante come un corpo morto al fondo della propria memoria, dove, un giorno, andremo a ricercarlo. Ci si stira, si fa qualche passo; pesando meno di un chilo, e la parola « felicità » sembra molto insufficente e limitata per descrivere questa sensazione.
Sono però gli incontri, numerosi e differenti, la scoperta dell'altro, la chiave del libro. Innumerevoli ritratti di nomadi, contadini, viandanti, operai, avventurieri, europei sperduti nel cuore dell'Asia, sono tra le pagine più belle del libro. Incontrare l'altro permette il confronto con il mondo, rimette in gioco le nostre certezze ma permette anche di ritrovare similitudini e somiglianze. E l'incontro può anche rivelarsi sorprendente e paradigmatico come quando, sulla strada per Chizaz, nell'est dell'Iran Nicolas Bouvier incontra in un camionista un volto familiare che finisce per riconoscere: Mentre il proprietario stava per soffiare sulla lampada scorsi per la prima volta il suo volto illuminato in pieno e capii cosa mi aveva intrigato: era il sosia di moi padre; un padre un po' invecchiato, annerito, umiliato, ma, in ogni caso, mio padre.
Oppure come nel Saki Bar di Quetta, dopo 1200 chilometri di deserto tra l'Iran e il Pakistan, ascoltano uno zingaro di una tribù della regione
Poi cominciò a cantare, gli occhi bassi, con una voce rauca che passava come un filo di lana rossa tra le note nasali dell'armonium. Sorta di sospiri cantati che ricordavano in modo sorprendente le canzoni sevda della Bosnia. Ritrovavamo l'odore del peperoncino, le tavole basse sotto i platani di Mostar o di Sarajevo, e gli zingari dell'orchestra nei loro completi lisi, tirando sui loro strumenti come se bisognasse urgentemente liberare il mondo da un peso intollerabile. Era la stessa tristezza sfuggente e folle, l'incostanza, il seme di elleboro.[...]
Dopo una giornata faticosissima nel garage, il ritorno dei ricordi era come un paradiso. Il viaggio, come una spirale, saliva e ripassava su se stesso. Ci faceva un cenno, dovevamo solo seguirlo.
Non deve essere facile attraversare il mondo cercandone la chiave e uscirne incolumi. Arriva il momento in cui ci si pone la domanda: e ora? Nicolas Bouvier ha descritto in un altro libro Il pesce scorpione questo sentimento. Arrivati in Afganistan Thierry Verner e Nicolas Bouvier si separano. Thierry va a Ceylon dove l'aspetta la sua fidanzata, Nicolas vuole proseguire verso la Cina. Ma la frontiera è chiusa ed egli si ritrova a Ceylon, solo, senza soldi per andare in Giappone. È come un naufrago, assalito dalla malattia e dalla depressione. Venti anni dopo, nel 1975, per « fare i conti » con questa esperienza, ne fa una narrazione melanconica e appassionante che, in una prosa poetica e desolata descrive la sua discesa fino quasi alla follia e il suo ritorno alla vita.
Tornando da un viaggio siamo come dei galeoni, carichi di pepe, noce moscata e altre spezie preziose, ma tornati in porto, non sappiamo che fare del nostro carico.